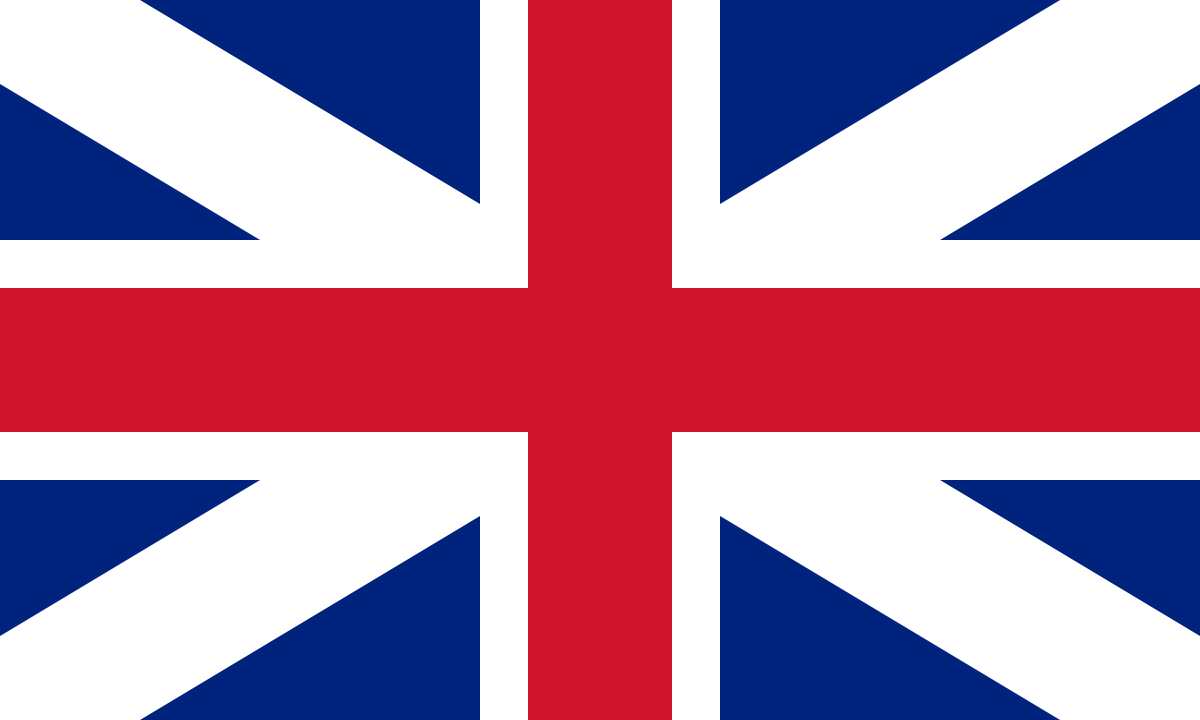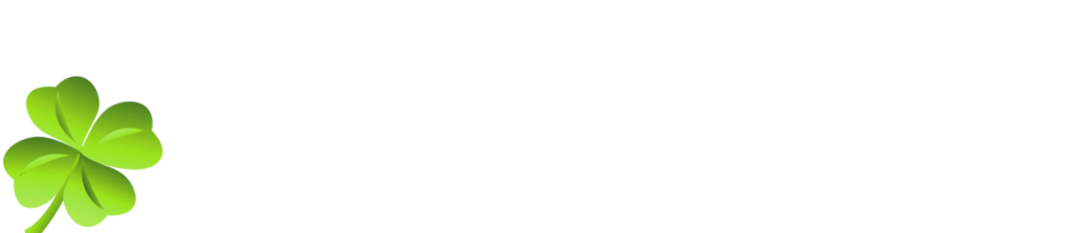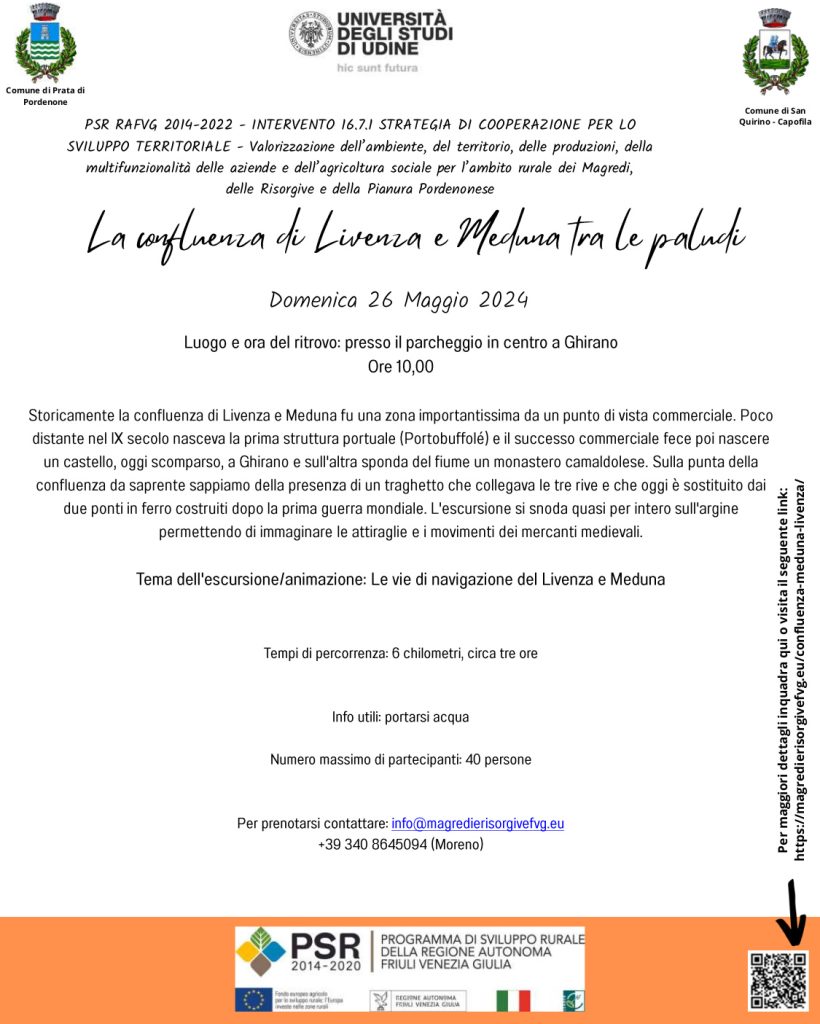Le vie di navigazione del Livenza e Meduna
Il punto di ritrovo è presso il parcheggio della piazza di Ghirano che è molto ampio e permetterà di raccogliere tutte le auto.
L’escursione ci riporterà al punto di partenza.
L’escursione è relativamente breve, ci impegnerà per circa tre ore con un percorso privo di dislivelli.
Partenza ore 10:00
Invia la richiesta di prenotazione a: info@magredierisorgivefvg.eu
oppure chiama: +39 340 8645094 (Moreno)
L’iscrizione all’escursione solleva gli organizzatori da ogni responsabilità derivante dalla partecipazione all’iniziativa per eventuali incidenti o infortuni
Tempo di percorrenza: 3 ore
Numero massimo di partecipanti: 40 persone
Portarsi acqua
Un inquadramento geografico
Alla confluenza tra i due fiumi c’era un traghetto che collegava le tre sponde in località Tremeacque (tra le acque) e qui sorse anche uno squero (laboratorio) per la costruzione e manutenzione dei burchi.
La località di Ghirano prende il nome da un antico luogo fortificato (girone) che non è mai stato realmente identificato e che è riconducibile al X secolo. Sappiamo invece che in età medievale i signori di Prata costruirono qui un castello per controllare il fiume e recentemente è stato individuato il luogo di questa fortificazione.
L’escursione segue un tratto del percorso ciclopedonale proposto con il progetto di turismo legato al Programma di Sviluppo Rurale che si snoda sul vertice dell’argine dei due fiumi con una importante vista sulle aree depresse delle golene dei fiumi. Golene che in occasione di importanti piene si riempiono d’acqua fino a sembrare degli enormi argini.
Il prato degli angeli
A valle della conflenza tra il Meduna, fiume alpino, e la Livenza, fiume di risorgiva, c’è una ampissima area depressa che da sempre si allaga in occasione di piene. Originariamente era un grande bosco pubblico come vorrebbe il toponimo Pra dei Gai sulla destra della Livenza, che ricorda il termine longobardo di Gahagi che significa appunto bosco.
Le aree poste lungo il Livenza a Ghirano erano chiamate invece Pra degli Angeli e oggi come in antico si allagavano in occasione delle piene del fiume Meduna. Oggi però la costruzione all’inizio del ‘900 dell’argine ha ridotto le aree di naturale espansione delle piene. L’ambiente tradizionale a differenza di oggi era esclusivamente prativo ed erano possibili solo alcune pratiche di coltivazione di alberi. Non è un caso, quindi, che nel Pra degli Angeli si trovi un enorme salice bianco che è stato sommerso per moltissime volte dalle acque. Camminare sull’argine permette di godere di un paesaggio unico privo di edifici in considerazione della sua speciale caratteristica idraulica. Tutto il territorio di Prata è circondato da argini particolarmente alti che testimoniano l’importanza delle piene e persino la strada di collegamento tra Ghirano e Portobuffolè la si è dovuta costruire sul vertice della struttura arginale.
Il traghetto di Tremeacque e il doppio ponte
Alcuni studiosi vogliono che Il nome di questa località derivi dal latino “inter ambas aquas” cioè “fra entrambe le acque”. Questo luogo era anche il punto di incontro dei due traghetti del Livenza e del Noncello che avevano diversi terminali in terraferma, Portobuffolé il primo e Pordenone il secondo, ma che erano ospitati sulla stessa riva del Vin a Rialto. Il traghetto di Tremeacque invece era di passo e per secoli fu gestito dalla famiglia Dall’Ongaro che qui aveva la sua residenza e anche uno squero per la riparazione dei burchi. Nel 1805 quell’attraversamento veniva descritto così: Un passo a Tremeaque e Meduna, essi si compongono di barche a fondo piatto per carri, sui quali può essere trasportato un carro grande a doppio tiro; poi su una chiatta per pedoni che contiene 12 uomini. Entrambi questi passi appartengono alla riva sinistra”.
Sul lato di Mansuè, presso un modesto fabbricato, nacque Francesco Dall’Ongaro, il famoso scrittore risorgimentale che descrisse nei sui scritti la terra natale e il paesaggio di Tremeacque in un articolo del 1840 pubblicato nella “Favilla” la rivista triestina che all’epoca dirigeva.
Lontano dalle rive della Livenza con nostalgia confessava che “Mi chiamava potentemente il mio Friuli, questa terra ove nacquero i miei maggiori, quest’aria ch’io respirai fanciullo, e mi riempie d’una vita novella sempre ch’io la respiro. […] io nacqui sulle rive all’azzurra Meduna. Perdonatemi, o diletti parenti: ma se v’è luogo in cui la vostra lontananza mi riesca men grave, egli è qui dove bacio ancora i pioppi ch’io vidi bambino, la terra che prima sostennemi, la chiesa dove io fui battezzato, quei primi volti a cui s’accostumarono gli occhi miei. Queste soavi memorie, e l’animo ospitale, e l’aria franca e non adulatrice che distingue fra tutti l’abitatore di questa contrada, tutto ciò mi lascia prevedere, e quasi sospirare un momento, in cui potrò come il fiume che rientra nel mare da cui traeva l’origine, riposare anch’io le stanche membra, dove un giorno ne fui vestito”.
Il traghetto fu soppresso nel 1917 quando l’esercito costruì due ponti per garantire il sistema stradale della retroguardia. Pochi mesi dopo, durante la ritirata i due punti furono distrutti e poi ricostruiti nel 1922.
Il castello di Ghirano
Il 5 agosto del 908 L’imperatore Berengario I concedeva al Vescovo di Ceneda il porto di Settimo sulla Livenza, quindi l’attuale Portobuffolè. Oltre a quella struttura gli lasciava anche i boschi di Gaio e di “Girano” con una “corte”:
“unum portum in Liquentia quod Septimum dicitur et sicut predictum flumen oritur et defluit usque in mare de ambabus partibus ripe per quindecim pedes palisfìcturam, ripaticum, toloneum, mercatum iuris regni nostri seu quicquid ad eundem portum vel in eisdem fìnibus pertinere dignoscitur, nec non et silvam de Gaio et Girano cum corte”. Questa corte poteva essere un luogo fortificato a presidio del corso del Meduna. Anche il toponimo Ghirano sembra derivare da “girone” e quindi da una struttura fortificata.
In età basso medievale sappiamo che a Ghirano c’era un paese di contadini sottoposti ai signori di Prata.
Nel 1307 a Ghirano comparivano toponimi relativi ai meandri “in loco dićto Sacono, cui a mane & monte fiumen Medune labitur”, oppure un doppio meandro “in loco dicto in Sacilo”, oppure quello di Paludo “meridie flumen liquentie labitur”. Sul lato del Meduna il documento ricordava anche una terra in loco dićto Castello, cui a mane terra Nicolai de Prata”. Solo recentemente si è capito che il castello stava su una grande e alta ansa del Meduna sull’altro lato del monastero di San Martino. Non a caso nel testamento di Guecello di Prata del 1262 il castello di Ghirano risultava essere della famiglia e il testatore accordava delle donazioni anche al monastero che proprio la sua famiglia probabilmente aveva contribuito a insediare in quel punto. Anche il castello scomparve del tutto per la guerra del 1419 e il fatto che il sito sia stato usato per un certo periodo come cava per le fornaci di Rivarotta non lascia molte speranze di rintracciare in loco elementi di archeologia.
Oggi la forma del fossato originario è ancora bel riconoscibile nelle foto aeree.
La chiesa di San Pietro e il suo trasferimento
Scendendo dal’argine a poche centinaia di metri dallo stesso, si può visitare la chiesa di San Pietro e San Paolo che probabilmente ha derivato il suo nome da un oratorio omonimo che era posto in riva al Meduna dove ora c’è il cimitero di Ghirano.
La mappa del 1829 Mostra chiaramente la strada che da Rivarotta scendeva al fiume e attraversava con un traghetto in occasione del borgo di Ghirano.
L’attuale chiesa parrocchiale di Ghirano era un altarino minore dedicato a San Francesco d’Assisi e la cui costruzione probabilmente risaliva al XV° secolo. L’originaria chiesa parrocchiale di Ghirano intitolata ai Santi Pietro e Paolo fu utilizzata fino al 1419, la data della grande battaglia tra Venezia e i signori di Prata dalla quale anche la chiesa sul fiume ne uscì disastrata, ma il cimitero rimase attorno a quelle rovine.
La chiesa di Ghirano fu ricostruita e consacrata il 20 maggio 1759, dal Vescovo mons. Lorenzo Da Ponte e diventò a tutti gli effetti chiesa parrocchiale nel 1770. Un nuovo progetto dell’architetto Antonio Maggion ridefinì l’architettura e il prospetto della chiesa, ma i lavori iniziati nel 1797 finirono solo l’11 giugno del 1846. Il campanile in stile storicista è dell’ing. Pietro dall’Ongaro (1947-51). All’interno erano conservate due importanti pale d’altare, una di Paris Bordone e una di Giovanni Girolamo Savoldo, ora alle Gallerie dell’Accademia di Venezia. Oggi all’interno si possono vedere pochi arredi storici e gli altari settecenteschi restaurati nel 2017.